
Due titoli consecutivi su Le Monde in prima pagina; Il 24 novembre, tre colonne: «6,9 milioni di francesi vivono con meno di 800 euro al mese».
Giorno seguente, a tutta pagina, allarmatissimo: «Intenzioni di voto per Le Pen, 17 %».
C'è un'evidente relazione fra le due notizie.
L'impoverimento storico delle popolazioni europee dovuto alla globalizzazione (la concorrenza salariale cinese o polacca) è in pieno corso (1) e alimenta l'insubordinazione popolare verso la politica «ufficiale».
Il «fascista» Le Pen preoccupa da decenni Le Monde, ossia la massoneria.
Molto tempo fa (doveva essere ai tempi di Mitterrand) il Grande Oriente di Francia convocò i responsabili dei due partiti ufficiali, socialisti e «gaullisti» (o pseudo), e li impegnò a non stringere mai alleanza con il Front National.
Cito a memoria - non ho tenuto il ritaglio dell'epoca - ma ricordo perfettamente che il patto ci fu e fu firmato.
In seguito, i trucchi operati sui collegi dalla «democrazia» (terminale come il capitalismo, con tassi di astensionismo spaventosi), hanno consentito questo: che un partito con il 15% dei voti non abbia un solo deputato all'Assemblea, mentre per esempio il partito comunista, praticamente estinto salvo in qualche roccaforte ex-operaia, ne abbia una ventina.
Le Pen viene continuamente demonizzato, il suo partito marginalizzato o trattato come non esistesse, oscure manovre e occulti finanziamenti vi hanno prodotto scissioni e defezioni di «fronti nazionali» dissidenti.
Di tanto in tanto, Le Monde commissiona un sondaggio per vedere se il favore per il Front è in calo: dopotutto Le Pen è vecchio, ha superato i 70…
Invece no: lo zoccolo popolare resta solido e duro, anzi si allarga.
Dunque sulle elezioni presidenziali del 2008 grava di nuovo l'incubo del 2002: quando ad uscire vincitori dal primo turno contro i gollisti non furono, come previsto e voluto, i socialisti al caviale, ma Le Pen.
Al ballottaggio, la sinistra chic dovette scegliere tra Le Pen e Chirac: ovviamente si turò il naso e votò quest'ultimo, anche perché istericamente indottavi da una campagna mediatica di terrorismo: pareva, a leggere i giornali, che le SS stessero per entrare di nuovo a Parigi.
Chirac fu votato da una maggioranza che lo detestava, come male minore: da qui la sua legittimità perlomeno imperfetta, che lo ha indebolito ed ha alienato ancora di più i francesi dalla politica «ufficiale».
Si stanno compiendo frenetiche manovre per impedire a Le Pen di guastare il gioco prefabbricato ponendo ancora la sua candidatura presidenziale: gli occorrono 500 firme di persone elette, e probabilmente non le avrà.
E se non si presentasse lui, per chi voterebbero i suoi elettori?
Anche questo ha chiesto il sondaggio.
Risposta: darebbero 8 punti in più a Sarkozy (la «destra» neocon), ma 5 punti a Segolène Royal, la candidata delle sinistre, portandola alla pari con il primo (ciascuno dei due candidati avrebbe, ad oggi, il 37 %).
Dunque molti elettori di Le Pen tendono a sinistra, non alla destra massonica ufficiale e liberista. Cosa nota: l'elettorato del Front è operaio e popolare, non chic, abita nelle banlieues dei disordini.
Segolène è un fenomeno metà mediatico e metà spontaneo, i suoi nemici la definiscono «la Madonna dei sondaggi» (intesa come la cantante, non la Vergine); è tutt'altro che una figura nuova di outsider come ama dipingersi.
Tuttavia, la sua campagna è interamente giocata su motivi di «populismo», e questo basta ad allarmare le oligarchie finanziarie.
Le hanno chiesto quale sia la sua idea a proposito della Turchia nella UE. Ha risposto: «La mia idea è quella dei francesi»: furbamente evasiva, ma inquietante per gli oligarchi già solo per questo appello al popolo.
E' significativo che Barbara Spinelli, l'amante di Padoa Schioppa che vive per lo più a Parigi a stretto contatto con la gauche-caviar, la attacchi e ripeta che Segolène non ha idee, che è opportunista.
Il Telegraph di Londra ne segnala però un'idea sgradita: la Royal parlato di un'«Europa forte», di un'Europa-fortezza economico-politica, il programma di De Gaulle.
«Miss Royal è fiduciosa che 'l'Europa può essere rilanciata con Germania, Italia e Spagna'», scrive il Telegraph, notando che dall'elenco è esclusa Londra.
E cita ancora Segolène: «Se altri Paesi vogliono starci, benissimo, ma non possiamo avere un'Europa di cui una parte va alla guerra in Iraq, un'altra non ci va, e noi tutti finiamo per pagare il conto».
Segolène Royal in tutto il suo «fascino» politico
La sua domanda di integrare la politica estera europea, trema il Telegraph, «ha toni stridentemente anti-americani».
E cita con allarme Gilles Savary, portavoce della candidata: «Dobbiamo essere vassalli degli USA? Siamo il 51esimo Stato americano?». (2)
Allarme, allarme: qui si rischia di rompere il fronte liberista globalizzatore; rialza la testa il «populismo», il che significa l'emersione di ciò che la finanza globale teme più di tutto: il «protezionismo», i dazi doganali a difesa delle reti sociali e del lavoro nazionale.
L'allarme è probabilmente prematuro, ma il capitale avventuriero mette le mani avanti.
Tanto più che simili sentimenti populisti emergono nel paradiso del liberismo feroce: negli Stati Uniti. (3)
Il voto di medio termine ha eletto in Virginia un senatore, James Webb, che ha condotto tutta la sua campagna denunciando la crescente iniquità economico-sociale, da 25 anni l'argomento-tabù del discorso politico americano.
In Montana, ha vinto un «populista» socialista di nome Jon Tester, accusato dall'avversario, il repubblicano Conrad Burns, di «fomentare la lotta di classe».
Una tale accusa in USA bastava, ancora pochi mesi fa, a segnale la fine di un candidato.
Oggi Tester ha replicato: «La mia classe è quella media; la vostra, senatore Burns, sono i vostri ricchi amici lobbisti di K Street» (la via dei lobbisti a Washington).
E' stato Burns a perdere il seggio.
Inaudito.
Nel 2004, il democratico John Edwards cominciò a far campagna sul tema delle «due Americhe»
(«i ricchi sempre più ricchi, i poveri più poveri, precari e indebitati») ma poi la abbandonò su consiglio dei suoi strateghi elettorali (e perse).
Oggi, quasi tutti i candidati democratici hanno almeno fatto un cenno alle disparità crescenti delle fortune.
Un sondaggio del Wall Street Journal ha rivelato, preoccupato, che 24 americani su cento citano l'iniquità nella divisione dei profitti come primo problema del Paese; e tutti accusano, come causa dell'iniquità, l'economia globalizzata e l'avidità dei grandi manager privati, che delocalizzano in Cina non solo i lavori subalterni, ma ormai anche quelli tecnologicamente avanzati.
Persino i giornalisti, serventi del globalismo ideologico, cominciano ad inquietarsi: molti lavori redazionali sono spostati in India, dove redazioni a contratto e anglofone sono disposte a lavorare per un terzo delle paghe americane.
Insomma, non si riesce più a impedire che il tema dell'ineguaglianza e del profitto eccessivo (tema «populista» per eccellenza) emerga nel dibattito pubblico e sui media.
A Parigi Segolène proclama di essere «la candidata dell'insoumission» (della insubordinazione), ma anche in USA gli americani affermano, ogni giorno con più coraggio, di essere stati ingannati.
I capitalisti gli avevano promesso: «Se studiate di più, resterete i primi nel mondo globalizzato, anche se perdete lavori operai, vi accaparrerete i lavori tecnologicamente più sofisticati».
Ma ora anche gli ingegneri elettronici, i progettisti e gli esperti di marketing perdono il posto perché India e Cina sfornano ingegneri, esperti elettronici e maghi del marketing a un decimo dei salari americani.
Se la qualità e lo studio fossero il fattore chiave, allora sarebbero vincenti quei 20-30 americani su cento che si sono riciclati, dati alla formazione permanente, ed hanno aumentato la loro produttività personale in modo prodigioso.
Invece, i vincenti sono solo l'1 % dei già ultraricchi nella finanza e nelle banche: quell'1 % che si accaparra oggi il 20 % del reddito personale americano, il doppio di quello che si accaparrava negli anni '70.
Ora, la classe mediana americana ha visto i propri redditi calare in termini reali, mentre gli speculatori, esaltati dai media, divoravano emolumenti da miliardi di dollari; lottano contro i costi crescenti dello studio, le rette universitarie ormai proibitive togliendo ai figli della classe media la speranza di migliorare o almeno restare a galla con la meritocrazia.
E con sempre maggiore lucidità denunciano la «deregulation» liberista; un sistema fiscale - concepito da Reagan e aggravato da Bush - studiato per favorire gli speculatori finanziari e gli insider delle multinazionali; l'abbandono totale, in nome del liberismo fai-da-te, della tradizione (che fu americana) degli investimenti pubblici che consentivano una certa uguaglianza iniziale nelle opportunità, il cuore del «sogno americano» come terra dove chi è bravo può emergere senza ostacoli.
Insomma si sveglia «il popolo», e i democratici vengono avvertiti dai poteri forti a non cedere al «populismo»; soprattutto, a non proporre misure protezionistiche contro la Cina…
I democratici vorrebbero ubbidire, come sempre, alla finanza.
Il democratico Jon Tester in una foto molto populista
Ma sentono che il loro elettorato sta diventando minaccioso.
Per esempio, un democratico non identificato ha confidato: «Se entro sei mesi non c'è un cambiamento di rotta in Iraq, la gente scenderà nelle strade come ai tempi del Vietnam».
Una novità inaudita viene qui ventilata: disordini popolari in USA.
A dirlo è stato un personaggio chiave della lobby ebraica, Giora Romm, il primo analista del Jewish Institute for National Security Affairs.
Questo è l'organo della lobby ebraica che tiene in pungo il sistema militare-industriale americano, il Pentagono e le lobby finanziarie USA ed è stato in grado di scatenarle nell'interesse di Israele, mandando gli americani a guerreggiare in Iraq.
Ma ora non ci riesce più, ha spiegato Giora Romm parlando a Gerusalemme, il 21 novembre scorso, davanti ai responsabili del ministero degli Esteri israeliano.
Costoro volevano assicurazioni sul fatto che Bush, azzoppato o no, bombarderà l'Iran per Giuda. Romm, che è pilota militare, vicedirettore dell'armata israeliana e capo dell'Agenzia Ebraica, ha raggelato i presenti: i poteri forti non riescono più a contenere la rivolta e la rabbia che salgono dal basso.
«Se Bush farà qualcosa di fisico contro l'Iran, subirà l'impeachment. Non v'illudete che Bush possa compiere un'altra azione bellica; ha perso ogni credibilità militare. L'americano medio non crede che l'Iran sia un pericolo per il suo Paese, e non sarà convinto da un'intelligence raffazzonata (come quella usata per l'Iraq)». (4)
Anche questa è insoumission, insubordinazione populista.
I democratici, temono i gestori del capitalismo speculativo, sono stati votati da questa rivolta: dovranno concedere qualche misura di protezionismo, qualche dose di «socialità» a difesa del lavoro nazionale, perché il loro elettorato li tallona, sospettoso, e li preme.
Sta avvenendo anche in Europa, e non solo in Francia.
In Olanda, l'establishment oligarchico rappresentato dai cristiano-democratici di Balkenende, liberista e fautore delle «riforme» (leggi: tagli alle sicurezze sociali) raccomandati dall'ideologia globalista, è stato sconfitto da un partito socialista estremista e anti-global sulla sinistra, e sulla destra dal Partito della Libertà, anti-immigrati. (5)
In Austria il cancelliere cristiano-democratico è stato battuto da un partito socialista che ha condotto una campagna populista.
Nella Germania della liberista Angela Merkel e delle «riforme» dure per tagliare i «costi sociali», il premier CDU del Nord-Reno e Westfalia ha rotto clamorosamente i ranghi, denunciando le «riforme» come inumane, eccessive e inique; ed ora si è posizionato alla sinistra dei socialdemocratici, con grande imbarazzo della Grosse Koalition.
Emerge il populismo, con le sue caratteristiche iniziali: non più passività ma rabbia attiva, militante; istanze «sociali» (di «sinistra») unite alla richiesta di ordine nazionale, magari xenofobo e per la «preferenza nazionale» (di «destra»).
E' un movimento che cerca a tentoni il suo leader, che interpreti le sue istanze, disprezzate dall'establishment e dalle varie oligarchie burocratiche.
Esiste da decenni, come dimostra lo zoccolo duro lepenista, fino ad oggi emarginato.
Ora la novità è che dei politici cominciano a cavalcarlo anziché spregiarlo.
E' stato notato che Segolène Royal, nei dibattiti TV, non si rivolge ai politici istituzionali suoi interlocutori nel dibattito, ma al popolo: questo colloquio diretto fra lei e la gente, che scavalca le istituzioni e i suoi figuranti, è ovviamente populista al massimo grado.
Ogni populismo invita, ovvio, uno stile «demagogico» del capo candidato.
La Royal, dicono, è opportunista.
Deve il suo seguito al suo charme, e al suo sorriso; ma non ha un programma definito, anzi si guarda bene dal definirlo.
Vero.
Ma nella temperie emergente che gli avversari chiamano populista, questi non sono difetti fatali.
Il successo dipende assai poco dalle qualità oggettive del capo-demagogo, e molto più dalla fiducia che il «popolo» gli tributa; perché un popolo che ha fiducia mobilita le sue proprie energie, che invece nega o che sono mortificate dalle oligarchie che sgovernano il mondo ormai da vent'anni.
In questo senso, William Pfaff (6) paragona il clima che circonda Segolène Royal a quello che avvantaggiò Franklin Delano Roosevelt nella sua prima presidenza, quando l'America lo votò perché sprofondava nella recessione provocata dalla finanza liberista nel 1929, e Roosevelt promise il «New Deal», ossia un nuovo patto sociale.
«Roosevelt nel '32 non aveva alcuna idea di come avrebbe fatto il New Deal», dice Pfaff: «Era una frase propagandistica che aveva buttato lì a caso nel discorso di accettazione» alla candidatura presidenziale.
«Ancor meno lo sapevano i suoi consiglieri universitari ed economisti professionali. Ma lo sapevano le migliaia di persone che le idee le avevano, e che erano pronte a lavorare con lui, e che lui seppe ascoltare. Furono queste migliaia ad improvvisare il New Deal. Molte cose non funzionarono; e quelli ritentarono di nuovo. Alla fine ne risultò un insieme non programmato di innovazioni che diedero agli USA una originale e pragmatica risposta alla grande depressione».
La descrizione è parecchio idealizzata, ma coglie l'essenziale: Roosevelt si limitava a parlare al popolo a fianco del caminetto, a dire frasi come «non dobbiamo avere paura d'altro che della paura stessa», e il popolo si sentì paternamente capito, rassicurato e guidato.
In Europa, come noto, la rivolta popolare dovuta alla grande depressione degli anni '30 originò gli autoritarismi social-nazionali, i fascismi.
Col loro corredo di dirigismo economico, autarchia, disciplina, fiducia mistica nel capo - e militarismo.
In quella forma il populismo non tornerà.
I fascismi furono fenomeni storicamente irripetibili, l'opera di Paesi demograficamente giovani e di giovani demagoghi, la cui gioventù per di più era appena uscita dalla grande guerra, dove aveva appreso la solidarietà fortissima che si instaura tra combattenti che rischiano insieme la morte, l'obbedienza funzionale alla gerarchia degli ufficiali, e l'uso delle armi; anche a sinistra la classe operaia comunista fu organizzata come «armata del lavoro».
Sarà interessante vedere che forma prenderà il populismo in un'Europa demograficamente spenta, fatta di anziani con figli trentenni a carico e disoccupati cronici; un'Europa che non ha ambizioni ma solo impulsi difensivi dello status quo, e per di più - assuefatta agli edonismi di bassa lega indotti da 60 anni senza guerra e senza privazioni, secolarizzata e scettica - non ha alcuna disponibilità al sacrificio in nome del bene comune patriottico.
Ma il populismo riemerge, ed ancora una volta esige capi in cui possa avere fiducia, che ascoltino il popolo anziché le lobby e gli interessi costituiti, che salvi il lavoro con dazi, che lo diriga secondo un progetto.
La morte nei giorni scorsi di Milton Friedman - il monetarista che fu l'autore spirituale del liberismo senza limiti, il dittatore e sacerdote supremo dell'ortodossia privatizzatrice e anti-sociale - è in questo senso un auspicio: un'epoca tramonta.
Persino il Financial Times ricomincia a parlare di John Maynard Keynes… perché il keynesismo è sempre meglio, per gli ideologi della globalizzazione, che il populismo, i suoi «demagoghi» e i suoi nazional-socialismi dirigisti.
E' in ogni caso il pendolo che torna indietro, torna ad oscillare verso una guida politica dell'economia e un suo controllo popolare.
Vedremo che forma prenderà.
Il populismo è stato sempre, per l'Europa, una grande forza storica, più convincente e più radicato della «democrazia» partitica e parlamentare che invece ci è stata imposta dai vincitori.
Ora, è possibile che il clima cambi in America - e allora verrà, come sempre, da noi come nuova moda culturale.
Per l'Italia, tuttavia, c'è un pericolo in più.
Milton Friedman in una foto recente
Da noi Berlusconi e Bossi hanno intrapreso precocemente la via populista (l'Italia è stata ancora una volta un laboratorio politico d'Europa) e l'hanno tradita, guastata, sprecando l'occasione forse irripetibile e svendendo il popolo.
Del nuovo movimento che verrà da fuori si proclamerà padrona la casta delle burocrazie che è attualmente al potere col nome falso di «sinistra», che potrà sostenere di essere sempre stata, in fondo, anti-capitalista, «sociale», dirigista e «operaia».
Qui è l'equivoco fatale.
In USA, il populismo americano ha lucidamente di mira i miliardari privati, gli speculatori, i super-manager: che sono pur sempre dei privati appunto, che scremano la maggior parte dei profitti a danno dei lavoratori; ma profitti privati.
Da noi, i parassiti di cui l'Italia deve liberarsi sono invece i miliardari pubblici, le caste burocratiche di Stato inadempienti, gli avidissimi saccheggiatori fiscali e le loro clientele privilegiate che si sono protette per tempo da ogni competizione, e che sono della più bassa qualità monopolista: proprio coloro da cui dobbiamo liberarci si prenderanno ancor più potere, proclamandosi per di più nostri liberatori dal liberismo selvaggio.
Dov'è, dov'è il demagogo in cui sperare?
Dov'è la nostra Segolène?
Maurizio Blondet
Note
1) L'impoverimento storico dei ceti medi europei dovuto all'entrata nel mercato globale di Cina, India ed Est europeo era prevedibile e largamente previsto: chi scrive lo ha denunciato in un libro del 2004, «Schiavi delle banche». Non lo si dice per vanteria, al contrario: se la cosa era evidente a un economista dilettante come il sottoscritto, tanto più doveva esserlo per gli economisti ufficiali, premi Nobel e banchieri centrali. C'è stato uno sforzo attivo e concertato per impedire che questo esito inevitabile arrivasse alla coscienza pubblica. Gli economisti Nobel, ufficiali e banchieri hanno invece promosso l'idea che l'apertura mondiale a Paesi con salari irrisori e costi della vita minimi, privi dei «costi» sociali, sindacali e assicurativi sul lavoro che sono la palla al piede dei sistemi europei, sarebbe stata benefica perché avrebbe ridotto i prezzi delle merci, avvantaggiando «i consumatori». E' una delle tante verità che sono state censurate dal liberismo terminale, concepito come un sistema di menzogna.
2) David Rennie, «Segolène urges Britain to choose between Europe and America», Telegraph, 22 novembre 2006. «Miss Royal was confident that 'Europe can be relaunched with Germany, Italy and Spain. It is perfectly possible to have treaties within the treaty, among four nations,' he said. 'If other nations want to sign up, that's good. But we cannot have a Europe where one part goes to war in Iraq, another part does not, and we all end up paying the bill. […] He demanded efforts to integrate foreign policy and cast that struggle in searingly anti-American tones. Mr Savary said: 'The question that needs to be asked is - do we want to be vassals of the United States, do we want to be a 51st state?'».
3) James Lardner, «Populism's revival» San Francisco Chronicle, 22 novembre 2006.
4) «La confusion du piège irakien et la crainte des dèsordres populaires au USA», Dedefensa, 24 novembre. Dedefensa cita un dispaccio dell'agenzia ebraica Ynet. news del 22 novembre sull'incontro di Girora Romm con l'establishment israeliano.
5) Wolfgang Munchau, «The Dutch are leading a popular rebellion», Financial Times, 27 novembre 2006. Si noti come il termino «popolare» o «populismo» sia accompagnato dal termine «ribellione»: le lobby temono la rivolta popolare, la revulsione di massa contro il capitalismo terminale che depreda la classe media.
6) William Pfaff, «Segolène Royal as Franklin Delano Roosevelt», Herald Ttribune, 1 novembre 2006. Gli articoli di questo notevole columnist americano, cattolico, che vive a Parigi, si possono leggere al sito www.williampfaff.com
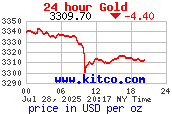

Nessun commento:
Posta un commento